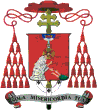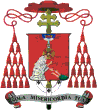I tre temi fondamentali dell’Istruzione «Il dono della vita»
1988
Il dibattito che è seguito alla pubblicazione dell’Istruzione “Il dono della vita” (DV) ha messo subito in luce la vera “materia del contendere”: la posta in gioco. Essa può essere ricondotta esaustivamente attorno a tre nodi problematici. Il primo, emerso soprattutto nella lettura fatta di DV da parte di alcuni biologi e genetisti, è costituito dalla possibilità o non di affermare qualcosa sull’uomo su cui la scienza non possa giudicare. Il secondo, emerso soprattutto dalla lettura fatta di DV da parte di alcuni studiosi di etica, è costituito dalla diversa, anzi opposta, definizione di ciò che è bene o male. Il terzo, emerso soprattutto dalla lettura fatta di DV da parte del giurista, è costituito dal sempre più urgente ed imprescindibile problema del rapporto fra legge morale e leggi civili. In altre parole: il dibattito ha affrontato una domanda epistemologica, una domanda etica e una domanda politica. La mia riflessione, pertanto, si articolerà in correlativi tre punti. Riflessione che si fa sempre più drammaticamente difficile. Come già notava san Tommaso (Qq. dd. de Malo, q. 6, ar. un., co), esistono discussioni che si svolgono sulla base dell’accettazione degli stessi fondamenti della scienza, nel cui ambito si svolge la discussione. Ma esistono contra-posizioni, in cui uno nega i fondamenti della disciplina stessa. Per esempio, non si può discutere di etica con uno che nega la libertà dell’uomo. È questa la situazione del nostro dibattito? Forse sì. Donde la necessità di una riflessione sempre più profonda ed impegnata.
1. La domanda epistemologico-antropologica: chi è l’uomo?
È nella logica stessa del sapere umano di procedere progressivamente verso una sistemazione ordinata delle varie conoscenze, verso una unificazione sempre più semplificante. In questa direzione, la biologia contemporanea è giunta alla individuazione di un “alfabeto della vita”, comune a ogni forma della stessa ed estremamente semplice: “dietro la complessità e l’impressionante varietà delle forme e delle funzioni, sono stati scoperti criteri quantitativi di similitudine per tutti gli esseri viventi” (B. Gunther, Dimensional analysis and theory of biological similarity, Physiological Reviews 55 (1975), 660).
Mi sia consentita ora un’osservazione molto più semplice. L’alfabeto, la morfologia, la grammatica di cui fa uso il bambino che scrive i suoi primi compiti di italiano sono identici a quelli di cui fece uso Dante nella composizione della Divina Commedia. Se noi prendiamo in esame i due “prodotti” nella loro obiettività, da questo punto di vista essi sono identici. Così come l’analisi chimica della Pietà di Michelangelo non dà risultati diversi dall’analisi chimica di un qualsiasi altro pezzo di marmo.
Notiamo tuttavia che questa unificazione — o meglio: considerazione unificante — ha un prezzo da pagare, piuttosto alto. La Pietà di Michelangelo è più che un pezzo di marmo chimicamente definito; la Divina Commedia è ben altro che lo scritto del bambino; quella considerazione impedisce di vedere il “più che”, di capire “l’altro che”. Molti lettori avranno già compreso di che cosa esattamente sto parlando. «L’analisi riduttiva è» certamente «lo stratagemma di ricerca più efficace che sia mai stato escogitato: ad esso si deve la formazione della scienza» (P.B. e J.S. Medawar, Da Aristotele a Zoo - Dizionario filosofico di biologia, voce: Riduzionismo, Milano 1986, 247). Ma dall’altra parte, occorre guardarsi dalla “malattia del niente altro che” di cui parla K. Lorenz (cfr. L’homme dans le fleuve du vivant, Paris 1981, 178 e Les fondements de l’éthologie, Paris 1984, 33).
D’altra parte è pure vero che mai Michelangelo avrebbe potuto scolpire la Pietà se non avesse avuto a disposizione del marmo; che Dante mai avrebbe potuto scrivere la Divina Commedia se non avesse avuto una lingua italiana già sufficientemente strutturata. Il cristallo di quarzo resta “esteriore” all’ippopotamo. Tuttavia, l’ippopotamo ha al suo interno dei veri cristalli, per esempio nella costituzione delle sue ossa possiede dei cristalli d’idroxiapatite. E così giungiamo ad un’altra constatazione: ci può essere un pezzo di marmo che non è la Pietà di Michelangelo, ma non viceversa; l’ippopotamo non può far parte di un cristallo, ma il cristallo può entrare nella costituzione di un ippopotamo. Esiste cioè una gradazione per successive integrazioni di un “meno” dentro ad un “più”. Se si debba intendere il “meno” “più” nel senso esclusivamente di “meno-più complesso” o in un senso più profondo, è questione centrale, ma che per ora non affrontiamo.
Questa prima serie di constatazioni pone già alcune domande che ci portano finalmente dentro al nostro problema.
A) Quando vogliamo sapere chi è l’uomo, quale è la via per giungere alla risposta, alla verità sull’uomo? È l’analisi riduttiva (senza dare al termine nessuna connotazione negativa)? E questa è la domanda essenziale di ciascun uomo: come si trova la verità?
Ma prima di rispondere, è necessario sapere di quale verità parla la domanda. È stato merito inapprezzabile di alcuni grandi maestri del pensiero occidentale (Agostino, Pascal, Kierkegaard) aver richiamato l’attenzione dell’uomo sul fatto che esistono due tipi di verità. Esiste una verità che non interpella minimamente la libertà dell’uomo (la chiameremo verità formale). Qualunque sia l’esito che avrà la discussione se sia più alto il monte Everest o il monte K2, l’esistenza di ciascuno di noi non cambierà minimamente. Ma esistono verità che, una volta conosciute, non lasciano più in pace la nostra libertà: non ci lasciano più come ci trovano (le chiameremo verità esistenziali). Esse ci costringono ad una scelta, poiché anche l’indifferenza di fronte ad esse, il dimenticarle completamente un istante dopo averle conosciute, è già una presa di posizione. È stata la tragica esperienza di Pilato di aver pensato di potersene lavare le mani, col risultato che di fatto ha condannato a morte un innocente.
Sono verità che ci fanno sapere che “siamo comunque imbarcati”, per dirla con Pascal.
La domanda parla di verità esistenziale, non di verità formale: per quale via l’uomo arriva a questa verità? La via non può essere quella dell’analisi riduttiva e chi percorre solo questa non giungerà mai a scoprire verità di tipo esistenziale. La ragione di questa impossibilità può essere mostrata in vari modi. L’analisi riduttiva presuppone una completa messa fra parentesi della irripetibile singolarità sia di chi mette in atto l’analisi sia di ciò che è analizzato. Di chi analizza: non è affatto necessario conoscere la vita di Einstein per capire le sue scoperte, mentre Agostino ha esposto le più profonde verità esistenziali in un suo scritto autobiografico, le Confessioni. Il fatto indica un modo preciso di essere ragionevole. Esiste un uso della ragione che può prescindere da chi lo mette in atto e ciascuno può sostituire e succedere a ciascuno: davanti al microscopio elettronico ci si può mettere in fila e a turno, uno dopo l’altro, ciascuno guarda. Ma esiste un uso della ragione che non può prescindere da chi lo mette in atto: l’intelligenza del teorema di Pitagora non è più difficile da parte di chi è un ladro che da parte di chi è onesto. Non così è, al contrario, per l’intelligenza del valore della giustizia. E, infatti, nessuno scienziato comincia tutto da capo, ma riceve ciò che ormai un tale numero di verifiche ha reso di fatto infalsificato. Mentre, nella soluzione di determinati problemi ciascun uomo deve ricominciare sempre da capo: non si può ritenere che è meglio subire una ingiustizia piuttosto che compierla, per il semplice fatto che così ha pensato Socrate, Tommaso Moro o Gandhi. Arriva prima o poi un momento nella vita di ciascuno in cui ciascuno deve, per conto proprio, dire se ciò che Socrate, Moro o Gandhi hanno detto, era vero o falso.
Di ciò che analizza: ciò che l’analisi riduttiva conosce è spogliato della sua singolarità come tale. Ma, la verità dell’uomo non è solamente conosciuta quando conosco i parametri fondamentali che lo definiscono come un individuo di una determinata specie vivente. Il fatto più importante è di sapere perché quell’individuo sono io e non un altro possibile. Nella catena della evoluzione della specie, ciascun individuo poteva essere sostituito da qualsiasi altro, indifferentemente. Mentre, non è affatto indifferente per ciascuno di noi che precisamente io ci sia. La verità (esistenziale) che ogni uomo deve cercare e su cui impegnarsi non è un “contenuto”; essa attinge al più profondo abisso dello spirito. E, pertanto, mentre la verità formale è oggetto di discussione, la verità esistenziale può essere solo oggetto di venerazione: l’uomo è dominato da essa e in questo dominio — come vedremo — l’uomo trova la sua libertà.
Se la via per giungere alla verità di cui parliamo non può essere quella dell’analisi riduttiva, quale è la via da percorrere, allora? Quale la via che porta alla verità che salva? Potremmo chiamarla la via della “soggettività-oggettiva”. E mi spiego. È la via il cui percorso comincia da una forte attenzione non principalmente a ciò che semplicemente avviene in noi, ma a ciò che è atto della nostra persona. Non per fermarci ad esso, ma per giungere a percepire quel soggetto umano che è ciascuno di noi. È una lettura-interpretazione delle esperienze essenzialmente umane che costituiscono la trama della nostra storia quotidiana, al fine di cogliere in esse l’intima natura del nostro essere persona.
B) È qui che si pone, allora, la seconda domanda: quale è il risultato cui si giunge percorrendo questa via? Che cosa si trova alla sua fine? Cioè: quale è la verità dell’uomo?
L’Istruzione DV ha precisamente alla sua base la percezione profonda di questa verità che sta oltre — non contro — quella verità sull’uomo che possiamo raggiungere mediante l’analisi riduttiva. A dire il vero, la Chiesa, da cui il documento emana, desume la sua conoscenza ultimamente dalla Rivelazione che Dio stesso ha fatto della verità dell’uomo. Essa, tuttavia, anche in questo documento è convinta che questa conoscenza non solo non contraddice la conoscenza che l’uomo può raggiungere senza Rivelazione, ma, al contrario, fino ad un certo punto le due conoscenze coincidono. E pertanto, anche a causa de ciò, questa Istruzione non è rivolta solo ai credenti.
B1) La prima e fondamentale affermazione concernente l’uomo è che la persona è più che ogni altra realtà: che essere qualcuno è essere più che qualcosa. È forse il punto nodale di tutto il discorso. E la percezione intellettiva della natura dell’essere personale nella sua superiorità nei confronti di qualunque altro essere non è facile da concettualizzare.
Procedendo per gradi, possiamo cominciare col dire che il colore bianco della parete della stanza è senza dubbio qualcosa di reale. Esso, tuttavia, nel suo esserci, è condizionato dalla parete cui inerisce: non ha un’esistenza autonoma, indipendente. In una parola: non esiste in sé, ma solo inerendo alla parete. In realtà, ciò che esiste è la parete bianca e non il colore bianco. Con questa semplice esemplificazione abbiamo già intravisto che nell’universo in cui viviamo possiamo distinguere due grandi classi di realtà: alcune esistono in se stesse e per se stesse, altre esistono solo se e quando ineriscono a una della prima classe. Tralasciamo la considerazione delle seconde e fermiamo la nostra attenzione solo alle prime. Osservandole con maggiore attenzione, possiamo vedere che anch’esse hanno un’esistenza assai fragile, perché radicalmente condizionata dal disporsi di tutto un complesso di elementi, i quali, precisamente, nel loro reciproco ordinarsi costituiscono la realtà che osserviamo: questo tavolo, questo fiore, e così via. A questo livello, le ricerche scientifiche ci hanno insegnato molte cose.
Entriamo ora un momento in noi stessi. La nostra esperienza interiore ci attesta un fatto mirabile e misterioso: il nostro permanere dentro un divenire continuo. Noi continuiamo ad attribuirci, a sentirci responsabili di ciò che abbiamo fatto dieci, venti anni fa. Sappiamo che, se escludiamo il sistema nervoso, dal punto di vista biochimico, la nostra realtà di oggi è completamente diversa. Donde deriva questa consapevolezza di un’identità permanente quando tutto concorre ad impedirla? Non c’è, alla fine, che una spiegazione. In ciascuno di noi c’è “qualcosa” la cui esistenza non è condizionata per niente dai vari processi biochimici che accadono in noi: possiede un essere non inerente ad essi, ma in se stesso e per se stesso. E questo “qualcosa” siamo noi stessi: è il nostro io personale. Egli è più che tutto ciò che possiamo constatare, verificare mediante una semplice analisi riduttiva. Egli non è la voce che parla, gli occhi intenti a vedere, le orecchie che si aprono al suono e così via. Neppure la somma, l’aggregazione di tutto questo. Ma è chi parla, chi vede mediante gli occhi, chi ode mediante le orecchie e così via. È il soggetto che allo stesso tempo trascende sopra tutte queste attività e, nello stesso tempo, la causa. Nell’ambito delle realtà che esistono in se stesse e per se stesse chi esiste in questo modo — cioè indipendentemente e non condizionato dai processi che lo esprimono — è ciò che chiamiamo persona. Essa si colloca al grado sommo dell’essere: non si può essere più che persona.
La profonda consapevolezza di questa condizione ontologica della persona si manifesta in molteplici esperienze quotidiane. Ne richiamo brevemente alcune.
Probabilmente la più eloquente è l’esperienza del nostro libero volere. Se noi consideriamo la nostra attività libera, vediamo che in essa esistono come due momenti: un momento decisionale e un momento esecutivo. Questo ultimo è condizionato certamente da una molteplicità di fattori che non dipendono da noi: tralasciamo la sua considerazione. Se, però, volgiamo la nostra attenzione al momento decisionale, noi constatiamo che esso dipende esclusivamente da noi. Nessuno al mondo può farci prendere una decisione, se noi non decidiamo di prendere quella decisione. Niente è più interno alla nostra volontà che la volontà stessa. Questo fatto che cosa rivela? Rivela che ciascuno di noi è qualcuno, che è in sé e per sé, dotato di una sua propria autonomia nell’essere. È una persona.
Un’altra esperienza molto eloquente è costituita da quella singolare sofferenza che ciascuno di noi prova ogni volta che si sente trattato come una cosa. Ciascuno sente che in quel momento gli è stata fatta ingiustizia: non gli è stato reso, cioè, ciò che gli è dovuto.
B2) La seconda e fondamentale affermazione concernente l’uomo è conseguenza della prima.
Da ciò che abbiamo detto finora segue logicamente un corollario. Se il nostro essere-persona non è condizionato da tutti quei processi biochimici che accadono in noi, il nostro essere-persona non può avere origine da essi, non può essere causato da essi. È il problema dell’origine di un essere-personale.
È questa una delle poche domande che l’uomo non può non porsi, o prima o poi. Essa, infatti, si radica in una consapevolezza ineliminabile dal nostro spirito: la consapevolezza di un “prima che io ci fossi”. E questa consapevolezza urge e ci fa chiedere: che c’è alle mie spalle? Che cosa spiega la mia venuta all’esistenza? Certamente, una (pseudo-)cultura può censurare questa domanda e l’uomo schiavo degli “idoli della piazza” può rimuoverla. Ma quando lascia la piazza culturale e se ne ritorna a casa, la domanda sorge: finito il gioco ricomincia l’esistenza.
Sgombriamo subito il terreno della riflessione da inutili questioni. Si noti, subito, che non è il problema di sapere se l’uomo è apparso come termine di una più o meno lunga evoluzione biologica: su questo lasciamo discutere chi ha la competenza di farlo. Il problema, infatti, non è di sapere come l’uomo è apparso nell’universo dei viventi. Il problema è di sapere chi o che cosa sta alle mie spalle, alle tue; di sapere che cosa spiega non la venuta all’esistenza dell’uomo, ma di me, di te. Perché io ci sono, tu ci sei? Ciascuno nel suo essere-personale.
Ora, a questa domanda non si possono dare che due e solo due risposte: alle mie spalle non ci sta nessuno / alle mie spalle ci sta qualcuno. Nessuno significa: ci sta la casuale convergenza di fattori; qualcuno significa: ci sta un atto di intelligenza e di volontà di qualcuno. Riflettiamo un momento su questo semplice dilemma. Da una parte, i due corni hanno qualcosa di comune. In ambedue i casi, il mio esserci dipende da un altro: o un impersonale disporsi di elementi o un Altro dotato di intelligenza e volontà. Ed è questo un aspetto comune che quando ci poniamo la domanda sull’origine, essa suscita in noi spesso un senso di malessere e/o di irritazione anche. D’altra parte, tuttavia, le due risposte sono veramente dilemmatiche: non ammettono una via di mezzo.
Se uno ha colto profondamente la natura intima dell’essere-persona di cui ho parlato poc’anzi, vede l’intima e necessaria coerenza fra questa percezione e la falsità del primo caso del dilemma. La venuta all’esistenza di ciascun individuo, essendo come tale condizionato nel suo essere dai processi in cui sussiste, potrebbe anche essere spiegata casualmente. La venuta all’esistenza di questa persona, essendo ogni persona incondizionata, nel suo essere, dai processi in cui sussiste, non può essere spiegata dall’iniziare di questi processi stessi. Insomma: l’affermazione che l’essere qualcuno è più che essere qualcosa e l’affermazione che l’essere qualcuno non è casuale, si tengono per mano: se cade l’una cade anche l’altra, se sta in piedi l’una sta in piedi l’altra.
Una conferma che l’origine del nostro esserci non è una impersonale casualità è che l’uomo di fatto può dire il contrario, ma non lo può pensare seriamente. Rendiamoci conto fino in fondo, fino alle ultime conseguenze dell’affermazione. Se io ho avuto origine casualmente, il mio esserci non ha in sé alcuna ragione, non ha in sé alcuna intelligibilità: è, per definizione, assurdo. Da ciò consegue immediatamente che la mia vicenda esistenziale non porta in sé alcuna esigenza intrinseca di essere vissuta in un modo piuttosto che in un altro: non ha in sé nessuna legge. Ciò che nasce per caso, per caso vive. Nessuno di fatto, nella sua vita, fa del caso la sua legge. Come ho detto: le verità formali si discutono; le verità esistenziali si venerano.
Ma che cosa, allora, significa che alle spalle di ciascuna persona ci sta qualcuno che lo fa essere con un atto di intelligenza e di volontà? Non pensiamo ai nostri genitori. La loro decisione procreativa non spiega ultimamente il nostro esserci. Essi volevano un figlio: non volevano ciascuno di noi nella sua singolare irrepetibilità. Anzi, nessun “qualcuno creato” può essere alle nostre spalle come ragione ultima del nostro esserci. Come abbiamo visto riflettendo sul nostro essere persona, esso si caratterizza per la sua emergente autonomia nei confronti di ogni realtà.
Leggiamo ora l’inizio stesso dell’Istruzione: «Il dono della vita, che Dio creatore e padre ha affidato all’uomo, impone a questi di prendere coscienza del suo inestimabile valore e di assumerne la responsabilità».
Se all’origine dell’essere-personale sta l’atto di intelligenza e di volontà di Qualcuno increato, esso non è autonomo nei confronti di questi. Ogni persona deve il suo esserci al Creatore e da Lui dipende continuamente come l’illuminazione dalla sorgente luminosa.
Da questo discendono conseguenze molto importanti. La prima è che l’esserci della persona — nel suo singolare statuto ontologico — è in se stesso e per se stesso un dono. Ciascuno di noi è gratuito: nessuno di noi è dovuto a nessuno, se non a chi lo ha voluto. Di noi stessi siamo debitori e, quindi, responsabili solo a Lui e davanti a Lui. La seconda è che la struttura intima del rapporto fra le persone è essenzialmente diverso dal rapporto fra le persone e le cose. Mentre in questo secondo, è possibile un rapporto di dominio e di uso, nel primo l’unico rapporto giusto è quello istituito dalla decisione della persona di relazionarsi all’altra in un piano di assoluta e totale uguaglianza. Vedremo in seguito che cosa significa tutto ciò.
B3) Esiste, infine, una terza e fondamentale affermazione concernente la persona umana, sempre connessa colla sua origine.
La domanda sul chi ha dato origine alla persona, pone inevitabilmente anche la domanda sul quando la persona è stata creata: cioè ciascuno di noi. È un problema assai difficile.
Ancora una volta il problema non è quello di sapere quando l’uomo ha fatto la sua apparizione in questo universo. È di sapere quando quell’uomo che è ciascuno di noi ha cominciato ad esistere.
Orbene, per un certo aspetto sembra che questa domanda non possa ricevere risposta. Se, come abbiamo detto, l’essere della persona è il termine di un atto creativo di Dio, non potendo noi avere una diretta conoscenza di esso, la domanda non ha risposta. È possibile una conoscenza indiretta o mediata? Ciò che noi conosciamo razionalmente di Dio trova la sua base sempre ed esclusivamente su ciò di cui noi abbiamo una conoscenza diretta, cioè il nostro mondo. Orbene ciò che ci svela l’essere personale sono le sue attività specifiche. Ne abbiamo sopra accennato: l’esercizio, per esempio, della nostra libertà. Da ciò dobbiamo allora concludere che la persona ha precisamente origine nel momento in cui è in grado di compiere queste attività? La conclusione in realtà non ci ha fatto molto progredire nella risposta alla nostra domanda. Che cosa significa “quando è in grado …”? O significa che, a sua volta, questa capacitazione all’attività è ancora una volta dimostrata dal suo esercizio effettivo e allora la risposta è in realtà la ripetizione della domanda, oppure significa che scomparendo completamente questa capacitazione (caso di gravissime lesioni cerebrali) o non essendo ancora apparsa (insufficiente sviluppo cerebrale) scompare la persona o non ha ancora avuto origine. Ora credo che ben pochi si sentirebbero di accettare questa seconda conclusione.
Dobbiamo allora rassegnarci ad un “lo ignoriamo e lo ignoreremo sempre”? Non lo possiamo: siamo costretti a rispondere. Infatti, nessuna persona è un’isola ed esistendo in rapporto con gli altri, questi devono sapere se hanno a che fare con una persona o con chi non è ancora o non è più persona: l’intima struttura del rapporto cambia essenzialmente, come abbiamo visto. E, dunque, si deve rispondere, quanto meno in ordine al modo di rapportarsi con la persona.
Due considerazioni, a questo punto, ci sono di grande aiuto. La prima è che ciascuna persona umana è competente per decidere questo. Nessuna cioè possiede autorità per dire: stante l’incertezza della cosa, decido che si cominci a trattare come persona o si cessi di trattare come persona da questo momento in poi. Se, infatti, esistesse una tale autorità, da questa dipenderebbe di fatto la persona come tale. L’essere persona è inscindibile dal suo essere considerata come tale, dal momento che la persona esige per se stessa, e non perché qualcuno lo decide, di essere trattata come tale. La seconda conseguente considerazione è che la risposta deve esclusivamente fondarsi su un dato obiettivo. E qui “obiettivo” va inteso nel senso strettissimo che ha nell’analisi scientifica strettamente intesa: prescindendo completamente dalla singolarità di chi analizza e di chi è analizzato. Ora un simile dato obiettivo esiste e oggi è conosciuto molto meglio di ieri: è il momento del concepimento. Obiettivamente qualcuno di nuovo biologicamente comincia in quel momento.
Si noti bene, per evitare dei corto-circuiti epistemologici, che la genetica non dimostra il momento dell’origine della persona. Essa dimostra un fatto (che rientra nell’ambito della sua ricerca) che, per ragioni filosofiche e non scientifiche, è giudicato l’unica base razionale per dare una risposta alla domanda sul quando ha origine la persona. E questa risposta, che parte da quella base, è elaborata non con argomentazioni scientifiche, ma filosofiche. Non è l’unico caso in cui una scoperta scientifica diviene la base per ulteriori conoscenze che non sono più scientifiche, ma meta-scientifiche.
La terza affermazione, dunque, è la seguente: la persona umana ha origine nel momento del concepimento, biologicamente inteso.
Questa affermazione unita con quella precedente getta una nuova luce sull’attività sessuale umana, come vedremo in seguito. Vorrei ora concludere con una riflessione, attinente ultimamente alla terza riflessione antropologica.
Può esistere un pezzo di marmo senza entrare a costituire una scultura michelangiolesca, ma nessuna scultura michelangiolesca può essere senza materia marmorea. La persona non è riducibile — come abbiamo visto varie volte — al suo corpo: essa è più che il suo corpo. Ma la persona umana sussiste nel suo corpo. Questo legame di persona-corpo merita di essere brevemente approfondito. L’unità del soggetto agente nella pluralità di attività fra loro essenzialmente diverse è un dato della nostra esperienza: è lo stesso e identico soggetto che vede, ode o tocca qualcosa e capisce un teorema di matematica o elabora le teorie scientifiche più astratte. Lo stesso e identico soggetto umano è corpo e più che corpo (spirito).
Da questa constatazione deriva una conseguenza assai importante. Chi ha visto l’essenziale superiorità dell’essere personale nei confronti di ciò che non è persona, vede che, entrando nella costituzione della persona umana, il corpo umano viene elevato allo stesso grado di essere della persona medesima. Se da un certo punto di vista il marmo di cui è fatta la Pietà di Michelangelo è lo stesso che di qualsiasi altro pezzo, in una visione completa delle cose quel marmo è essenzialmente diverso da ogni altro: esso esprime un atto puramente spirituale vissuto da Michelangelo, un’altissima ispirazione artistica. È il “corpo” di questa ispirazione. Se da un certo punto di vista il corpo di cui è fatta una persona umana è lo stesso che qualsiasi altro brandello di materia, in una visione completa dell’uomo è essenzialmente diverso da ogni altro: esso esprime una persona, un soggetto. È il corpo di questa persona. Distruggere un qualsiasi pezzo di marmo non è un grave danno per l’umanità; distruggere quel pezzo di marmo che è la Pietà di Michelangelo è danneggiare gravemente tutta l’umanità. Quel corpo è di una persona, è un corpo-persona: trattarlo come una cosa, un oggetto da esperimento, per buttarlo quando la ricerca è terminata, equivale a buttare una persona. Pretendere di manipolare il marmo della Pietà senza intaccare l’ispirazione artistica che l’ha plasmato è ridicolo, semplicemente perché essa si è incorporata in quel marmo. Pretendere di relazionarsi ad un corpo umano senza relazionarsi alla persona è impossibile, semplicemente perché essa si è incorporata in quel “materiale vivente”: è quel “materiale vivente”.
Ho parlato con Konrad Lorenz della malattia del “nient’altro che”. Questa malattia colpisce la nostra intelligenza in due forme: l’uomo non è niente altro che un’unità di processi o reazioni biochimiche - l’uomo non è niente altro che spirito. L’uomo è inscindibilmente l’uno e l’altro.
2. La domanda etica: come deve essere trattato l’uomo?
Nello svolgimento della risposta alla domanda epistemologico-antropologica abbiamo spesso toccato il confine del territorio etico, senza mai entrarvi. Cosa che cercherò ora di fare.
Credo che la migliore descrizione del modo con cui DV è stata accolta da parte di tutta una determinata “cultura” etica, sia stata fatta dal prof. G. Mathon, decano della Facoltà teologica di Lilla, quando ha scritto:
«Ci si chiede di fatto se l’analisi classica dell’atto umano, quale è quella messa in opera nell’Istruzione, corrisponde ancora, e fino a che punto, agli approcci che oggi ne fa l’uomo, segnato da una cultura che ha integrato le filosofie dell’intenzionalità, la psicologia e le altre scienze umane. Si può ancora pensare di evocare l’omicidio “in sé”, l’aborto “in sé” e qui la FIV-ET, indipendentemente non solo dalle circostanze, dalle intenzioni, ma più profondamente dal progetto che hanno coloro che vi ricorrono. Si confronti cio che è scritto della scienza e della tecnica, le quali richiedono per il loro intrinseco significato dei criteri provenienti dal di fuori di esse, dalla persona e dai suoi diretti... e ciò che è stato scritto sul procedimento della FIV-ET. Esso deve essere giudicato “in se stesso”.
Da quale antropologia deriva questa spaccatura?» (in Le don de la vie, ed. Cerf, Paris 1987, XX).
Di che cosa si tratta precisamente? Quale è in questo ambito la “materia del contendere”? L’Istruzione dà un giudizio di illiceità in sé della FIV-ET omologa (cfr. 2 B 5): un giudizio, cioè, che afferma essere fondato sulla procedura in se stessa considerata, prescindendo dall’intenzione di chi vi ricorre o di chi la mette in atto. Per il momento tralasciamo di vedere quali sono le ragioni di questo giudizio. Esiste un problema più generale e precedente: più radicale, emerso chiaramente nel dibattito seguito alla pubblicazione. E la domanda è la seguente: è corretto porre il problema di una natura etica di un atto umano, prescindendo o mettendo fra parentesi tutto ciò che riguarda le intenzioni, le motivazioni di chi compie quell’atto medesimo? Oppure una domanda simile è frutto di una pura astrazione che esistano atti in sé e per sé considerati che sono illeciti, prescindendo del tutto da che li precede o li segue?
Come è chiaramente accennato nel testo citato, chi nega la correttezza di questo modo di procedere nella riflessione etica, ritiene che la moralità dell’atto la si debba desumere dal “progetto” di vita di coloro che compiono l’atto in questione, nel caso la FIV-ET. Concretamente: non si vede come si possa dare un giudizio etico negativo sulla FIV-ET, quando chi vi ricorre è legittimamente sposato e non ha altra via per raggiungere ciò a cui l’amore coniugale è internamente ordinato. Entro un progetto di amore e vita coniugale, quell’atto si inserisce coerentemente e ne è una fondamentale espressione.
È bene far notare subito che non si tratta di una questione “di scuola”, ma di questione che nei suoi termini essenziali è fondamentale nell’etica e, quindi, per la sorte ultima della persona umana. Essa va, pertanto, rigorizzata nei suoi termini essenziali, dicendo subito di che cosa non si tratta.
Come possiamo verificare anche in ogni processo penale, per condannare un imputato non è sufficiente che egli abbia commesso il fatto contestatogli dalla pubblica accusa, ma è anche necessario che il fatto possa essergli imputato. E così anche nel discorso etico occorre distinguere accuratamente il giudizio che deve darsi sull’atto compiuto dalla persona dal giudizio che deve darsi sulla persona che ha compiuto l’atto: bisogna distinguere la moralità dell’atto dalla imputabilità della persona. Anche chi afferma che esistono atti che sono — considerati in sé e per sé — moralmente illeciti, non afferma che chi li compie è senz’altro moralmente colpevole. La questione, dunque, non riguarda questo secondo aspetto: si tratta di sapere se un atto può già avere in sé e per sé di che per essere eticamente giudicato oppure se esso, in ordine alla sua qualificazione etica, debba sempre essere riferito o relazionato alla persona (che lo compie): che in quell’atto esprime-realizza un “progetto” di vita.
Per comodità e poiché DV parla solo di atti di questo genere, limitiamo la nostra attenzione agli atti mediante i quali un uomo istituisce un rapporto con un altro uomo, ma facendo su di essi una riflessione di carattere generale, valida cioè per ogni genere di atto umano.
Un vecchio adagio dice “volenti nulla fit injuria” (a chi acconsente non si fa nessuna ingiustizia). Da esso sembrerebbe derivare che la costituzione di una comunità e di un rapporto inter-personale, costituzione che accade sempre mediante gli atti delle persone che vi entrano, ha come unica condizione, dal punto di vista etico, che esista un libero consenso da parte di tutti circa la struttura, la natura del rapporto che si vuole istituire. Se, cioè, la progettazione del rapporto inter-personale è consapevolmente e liberamente accettata, la sua coerente realizzazione successiva non pone più per sé problemi etici.
Se prendiamo per vera questa tesi, dobbiamo logicamente ritenere vere tutte le implicazioni o meglio le sue condizioni teoreticamente necessarie. Vediamole.
La prima è che prima della progettazione del rapporto inter-personale, non è possibile pensare l’esistenza di un “bene-male” morale, semplicemente perché un “prima” non esiste nel senso morale, dal momento che il giusto o l’ingiusto in un tale rapporto è precisamente istituito e stabilito dalla consapevole e libera progettazione del rapporto stesso. In altre parole: è giusto quel rapporto che tale, cioè giusto, è stato ritenuto.
Nel rapporto inter-personale l’uomo giunge alla sua perfezione: perfeziona il suo essere personale. Poiché la giustizia è costituita dal libero progettarsi della persona, ciò che perfeziona, ciò che fa essere l’umanità di ogni uomo è deciso dalla libertà. Il che implica — ed è la seconda condizione teoretica — che non si dà una natura umana che sia prima della coscienza che l’uomo ha di sé. О — il che equivale — l’uomo è semplicemente ciò che ha coscienza di essere. In questo senso si è detto e ripetuto che è la natura dell’uomo non averne alcuna.
Possiamo fermarci a questo punto. Quando si afferma che non è possibile dare un giudizio sull’atto umano se in sé e per sé considerato, ma solo se l’atto è rapportato o relazionato al progetto di vita di chi agisce, delle due l’una. O il riferimento al progetto di vita è il riferimento ultimamente decisivo e decidente, in quanto fondamento ultimo del giudizio etico oppure il progetto di vita deve essere esso stesso riferito ad un ulteriore fondamento che giudica il progetto medesimo: non si dà una terza possibilità. Nel primo caso è logicamente necessario affermare che, ultimamente, è l’uomo a decidere ciò che è bene o male moralmente. Nel secondo caso si afferma l’esistenza di una verità sul bene e sul male che trascende il conoscere ed il progettare umano, dalla quale questi sono giudicati.
Il primo caso. La negazione della possibilità di un “procedere oltre” la comprensione che l’uomo ha di sé nel senso suddetto, è coerente colla negazione della verità della creazione dell’uomo: colla negazione che all’origine della persona stia un atto creativo di Dio. Se alle mie spalle sta un progetto creativo, infatti, il primo e fondamentale dovere etico è la mia personale conformità a questo progetto. Il “mio” progetto deve essere in consonanza al progetto di Chi mi ha voluto. Se, al contrario, alle spalle della mia libertà non sta alcuna altra libertà progettante, è la mia libertà a decidere in maniera del tutto autonoma di me stesso. E in questo contesto, è vero che parlare di un atto in sé e per sé moralmente lecito o illecito non ha alcun senso. Ma, in realtà, non ha solo senso questo, ma anche un giudizio etico sul progetto stesso. In una parola: non ha del tutto senso parlare di etica.
Il secondo caso. L’affermazione dell’esistenza di una verità sul bene e sul male, che trascende la ragione e la libertà umana, è coerente con l’affermazione della verità della creazione di cui abbiamo parlato nel punto precedente. E in questo contesto è possibile dare un giudizio etico sull’atto umano in sé e per sé considerato. È questa possibilità che ora dobbiamo vedere.
Dobbiamo prima, tuttavia, fare alcune chiarificazioni terminologiche, utili soprattutto per chi non è pienamente addentro alla riflessione etica sistematica. Quando parliamo di “atto in sé e per sé”, parliamo di un atto come esso ci è dato di conoscere attraverso semplicemente ed esclusivamente attraverso la sua definizione essenziale. Quando, per esempio, parliamo di “adulterio in sé e per sé”, intendiamo semplicemente la “congiunzione sessuale fra un uomo sposato e una donna non sua moglie o viceversa”; quando, per esempio, parliamo di “FIV-ET in sé e per sé”, intendiamo semplicemente quel processo ordinato al concepimento, il cui protocollo è descritto oggi nei vari testi di ostetricia, prescindendo dal fatto, per esempio, che chi lo chiede sia sposato o non. È usuale anche l’espressione “l’atto considerato nella sua natura”, che è espressione sinonimica, in quanto la definizione essenziale è lo strumento logico mediante il quale l’uomo conosce la natura delle cose. Che di un atto si possa parlare in questo modo, nessuno lo mette in dubbio. Si deve fare una seconda chiarificazione molto più importante, per non cadere nell’errore di pensare che le proposizioni etiche, il cui soggetto sia un atto in sé e per sé considerato, e il cui predicato sia una qualificazione etica (es. “l’adulterio è in sé e per sé illecito”), siano mere tautologie, come qualcuno ha pensato.
Ogni giudizio — espresso attraverso una proposizione — è razionale se e in quanto esso afferma/nega ciò che afferma/ nega, applicando un “criterio” razionalmente precedentemente dimostrato o per sé evidente: diversamente non di un giudizio, cioè di un atto razionale, si tratterebbe, ma di qualcosa d’altro (per esempio, della manifestazione di una propria emozione). Orbene, quando il sapere etico enuncia un giudizio su un atto in sé e per sé considerato, esso fonda l’enunciazione sul rapporto fra questo atto (noto per definizione essenziale) e la natura della persona umana, conosciuta attraverso la ragione (e, dal credente, la Rivelazione). Il criterio, dunque, del giudizio etico è questo rapporto: se è un rapporto di “conformità” l’atto è eticamente lecito, se è di “difformità” l’atto è eticamente illecito.
Resta, allora, da chiarire, da definire rigorosamente questi due termini “conformità-difformità”, che sono, pertanto, termini centrali nell’elaborazione della riflessione etica, scientificamente condotta. Possiamo aiutarci con un esempio. Se una persona si ponesse in una piazza nel momento di maggior traffico ed esclamasse: “che bellissima musica si ode!” e in seguito, questa stessa persona, rientrata a casa, si mettesse all’ascolto di un quartetto mozartiano ed esclamasse: “che insopportabile rumore!”, noi diremmo che, quanto meno, questa persona è totalmente carente di ogni senso musicale. La ragione del nostro giudizio è semplice: la “reazione” non è adeguata alla realtà del suono udito; è una reazione sproporzionata. E questa ragione è ovviamente fondata su ciò che è il rumore del traffico, la musica del quartetto e sulla loro essenziale diversità dal punto di vista estetico. Si faccia bene attenzione: dal punto di vista estetico. Infatti, da altri punti di vi sta (per esempio della scienza che studia come si trasmettono i rumori) fra i due fatti possono non risultare differenze sostanziali. L’esempio, credo, è illuminante.
Di fronte alla persona umana si possono avere “reazioni” molto diverse o — il che è lo stesso — la persona umana può essere considerata e trattata in modi molto diversi. Se considero la persona umana in ciò che essa è ( cioè la natura della persona umana), vedo che essa è essenzialmente diversa da tutto ciò che non è persona, come abbiamo visto nel primo punto della nostra riflessione. Da ciò consegue che trattare la persona non come persona ha lo stesso senso che considerare un quartetto di Mozart alla stessa stregua che il rumore del traffico: questo è un non-senso estetico, quello è un non-senso etico, cioè è male eticamente. Si faccia bene attenzione a questo punto. Non si dice che la persona debba essere studiata solo in quanto e in ciò che la fa essenzialmente diversa da ciò che non è persona (la musica di Mozart può servire anche per misurare l’udito di una persona). Si dice che essa deve sempre essere trattata come persona, anche quando la studio non propriamente come persona (di qui l’illiceità di certe ricerche sugli embrioni, anche se mi fanno acquistare nuove conoscenze). In una parola: il punto di vista dell’etica è la persona come persona e, pertanto, l’etica non si fonda su una qualsiasi conoscenza della persona, ma solo sulla conoscenza della persona come persona (= antropologia filosofica e teologica e non quella culturale o altro).
Ritorniamo ora all’esempio di un giudizio etico; l’adulterio è in sé e per sé illecito. Questo giudizio suppone già nota la definizione essenziale di adulterio: che si sappia, cioè, di che cosa si parli. Se io relaziono l’atto dell’adulterio alla persona in quanto dotata della capacità di congiungersi sessualmente, nessun giudizio etico è possibile e, infatti, da questo punto di vista non c’è nessuna diversità essenziale fra adulterio e atto sessuale coniugale. L’impossibilità deriva dal fatto che siamo ancora fuori del punto di vista etico. Infatti, il possesso da parte della persona umana della capacità di congiungersi sessualmente non caratterizza affatto la persona come persona: anche l’animale la possiede. Ciò che caratterizza quella capacità come capacità della persona come persona è che essa è espressione di un amore definitivo per sé ordinato a dare origine a un’altra persona. È a questa capacità che l’etica relaziona l’atto dell’adulterio affermando la “difformità” di esso da quella e, dunque, dalla natura della persona come persona.
Il problema allora è di sapere se esiste una “natura della persona umana” che, in quanto conosciuta dalla ragione, diviene il termine a cui è confrontato l’atto della persona medesima, confronto in cui si pone la moralità dell’atto medesimo. È questo il nodo centrale del problema: come deve essere trattata la persona umana? Prima di rispondere è necessario chiarire e precisare alcuni termini in cui la domanda è formulata. E il primo ad averne bisogno è “natura”. Essa è presa nel senso meta-fisico e non nel senso scientifico. Può essere utile giungere alla determinazione di questo significato metafisico, percorrendo brevemente il cammino che ad essa conduce.
L’esperienza che l’uomo fa di se stesso gli rende testimonianza di alcuni fatti assai importanti. In primo luogo, l’uomo può mettere in azione tutto un complesso di dinamismi, di facoltà operative che non si collocano tutte sullo stesso piano: l’uomo può agire spiritualmente e può agire fisicamente o psichicamente. Ma, nello stesso tempo, la medesima esperienza gli mostra che non sono due soggetti che entrano in azione, ma è lo stesso e identico soggetto che agisce. Da questa constatazione dobbiamo inferire l’esistenza di un soggetto sussistente spiritualmente-psicofisicamente.
Questa singolare costituzione dell’essere umano pone una serie di problemi filosofici. Come è possibile questa unità del soggetto che agisce mediante dinamismi essenzialmente diversi? L’unità che si mostra all’interno dell’operare presuppone un’unità nell’essere della persona. Ma, il nodo teoretico del problema è precisamente questo: come è possibile il costituirsi in unità di una realtà come la persona umana, composta di materia (il corpo) e di spirito? La risposta a questa domanda si articola in due momenti.
Il primo. La personalità — il modo di essere proprio della persona: in sé e per sé — è connessa necessariamente allo spirito. Lo spirito è persona e l’uomo deve il suo essere persona al suo essere spirito. Da ciò consegue allora che la corporeità non è elemento costitutivo della persona? Che il corpo non è persona e che la persona umana è il suo spirito, ma semplicemente ha un corpo? Il secondo momento della nostra risposta mostra come questa conclusione non sia teoreticamente inevitabile. Infatti, l’essere — come la scuola platonica aveva profondamente percepito — è per sua natura comunicabile, per la sua ricchezza interiore. L’uomo, nella sua costituzione, è un “caso” di questo fondamentale teorema metafisico. Lo spirito comunica il suo essere al corpo, elevandolo alla sua dignità. L’essere per cui la persona è, è uno solo, quello che la fa essere spirito. Questo stesso essere, comunicato al corpo, fa sì che la persona umana sia un soggetto sussistente spiritualmente-psicofisicamente. La persona umana è persona corporea; il corpo umano è corpo personale. La costituzione metafisica della persona umana è questa.
Non è necessario proseguire ulteriormente nella determinazione di questa costituzione. Ciò che ho detto, mi sembra che sia sufficiente per capire che quando si parla di “natura della persona umana”, non si enuncia un concetto né scientifico, né pre-scientifico, né anti-scientifico. Semplicemente si enuncia un concetto metafisico, raggiunto cioè mediante un uso della ragione proprio della metafisica.
Il secondo termine bisognoso di precisazione è quello di “atto umano”. Esso non connota qualsiasi esercizio dei vari dinamismi umani, ma, parlando dal punto di vista rigorosamente etico, solo l’esercizio del dinamismo volitivo libero. Atto umano nell’etica è formalmente equivalente ad atto volontario libero. Tuttavia, ciò non significa: “esclusivamente equivalente”. L’atto del volere ha sempre un oggetto: è volontà di qualcosa. E, pertanto, la decisione libera prende corpo in un atto, la cui struttura o costituzione precede la decisione libera di compierlo. Poiché la volontà, per decidersi, deve aver chiaro ciò a cui si decide (ignoti nulla cupido, dicevano i latini). E così, l’atto umano nella sua intera realtà e verità sussiste in due elementi che lo costituiscono: la libera e la “materia” o contenuto della decisione libera. L’atto umano della FIV-ET, per esempio, è costituito, dal punto di vista della considerazione etica, dalla decisione libera (dei coniugi che la chiedono e del tecnico che la realizza) e dal preciso protocollo in cui consiste quel procedimento. Se ci domandiamo quale di questi due elementi costitutivo è più importante, bisogna rispondere distinguendo. Dal punto di vista puramente formale, il secondo; dal punto di vista esistenziale, il primo. E mi spiego. Dal punto di vista di un sapere etico scientificamente elaborato, la domanda preliminare alla questione sulla liceità di un atto è la domanda sulla natura dell’atto da giudicare eticamente. È la domanda seguente: che cosa è, in che cosa consiste l’atto? Ora è chiaro che la risposta a questa domanda, la definizione cioè dell’atto, non può essere cercata sul versante della decisione libera, ma sul versante dell’oggetto della decisione libera. In questo senso, nella prospettiva della scienza etica, la considerazione oggettiva, strutturale dell’atto è e deve essere prevalente. Dal punto di vista, tuttavia, della imputabilità dell’atto alla persona, e quindi della rilevanza che l’atto ha nel concreto e personale orientamento di ciascuno alla sua salvezza eterna, la considerazione del coinvolgimento della persona nel suo agire è la considerazione prevalente. Ma questa considerazione esula dal discorso etico scientificamente elaborato.
L’ultimo termine che esige di essere precisato è quello di “conformità alla / difformità dalla” (natura della persona di un atto umano). È il termine chiave, poiché esso connota il concetto che definisce il criterio del giudizio etico. Questa precisazione esige alcune considerazioni preliminari di carattere antropologico generale, riguardanti il rapporto fra la persona e il suo atto. L’atto è la perfezione ultima della persona. Quando, per esempio, la persona compie un atto di intelligenza, mediante il quale conosce la verità, essa raggiunge una perfezione nuova: il suo essere è arricchito. Infatti, una sua potenzialità — la sua capacità di conoscere il vero — è stata potenziata. In quell’atto di conoscenza, la persona è divenuta più perfetta. E così ogni altro dinamismo o facoltà operativa.
Esiste, tuttavia, una fondamentale differenza fra i vari dinamismi umani e correlativamente fra i vari atti che perfezionano la persona. L’esempio appena fatto mostra che l’atto di cui si è parlato, ha perfezionato la persona in quanto intelligente, non in quanto altro. E questo è vero di altri dinamismi. Esiste un atto che perfeziona la persona non in quanto è questo o quello (intelligente...), ma semplicemente in quanto persona? Un atto, cioè, per il cui compimento si deve dire non: chi lo ha compiuto è divenuto una persona intelligente..., ma semplicemente: è divenuta una persona più persona? Questo atto, correlativo alla facoltà di decidere liberamente, è l’atto della volontà: chi compie un atto libero eticamente buono semplicemente diviene più persona, arricchisce se stesso nel suo essere personale. Il lettore attento avrà notato subito l’aggiunta “eticamente buono”. Non il puro e semplice fatto di agire liberamente perfeziona la persona, ma l’agire liberamente ponendo gli atti esigiti dalla natura propria e specifica della persona umana in quanto tale.
Il giudizio etico è il termine di un processo teso a verificare precisamente il rapporto esistente fra l’atto, considerato nella sua obiettiva struttura, e la persona umana in quanto tale: se l’atto realizza la intrinseca natura della persona (“conformità”), è eticamente buono; se non realizza la medesima (“difformità”), è eticamente illecito.
Si può ora vedere come eliminando dal discorso etico il riferimento alla obiettiva struttura dell’atto, in realtà è il discorso etico come tale che è privato di senso. Infatti, una volta eliminato questo riferimento, gli esiti della riflessione etica possono essere due.
O resta solo il riferimento alla libertà pura, cioè priva di qualsiasi contenuto, e allora, alla fine, agire eticamente bene equivale esaustivamente ad agire liberamente: il che è come dire che non esiste più una regola per l’esercizio della propria libertà, che non esiste più un “bene-male morale”. O resta il riferimento alle conseguenze del proprio atto. Ma, in realtà, questo riferimento non risolve il problema: lo sposta solo di un passo. In base a quale criterio si giudicano le conseguenze? Di quali conseguenze si tratta: di quelle prevedibili, penso? Ma, per definizione, si tratta di un calcolo di probabilità che deve bilanciare pro e contra: in base a quali criteri si opera questo bilanciamento?
Ritorniamo ora alla lettura di DV. Più precisamente, delle pagine dedicate alla soluzione del “simple case” della FIV-ET. La logica etica messa in atto in quelle pagine apparirà ora più chiara. La domanda fondamentale è semplice: come deve essere trattata la persona umana? Cioè: quali atti ne distruggono o ne promuovono l’essere suo proprio? La persona umana dei coniugi, del concepito, del tecnico. Si istituisce un confronto fra la natura della persona umana e l’intima struttura obiettiva del procedimento FIV-ET. Da questo confronto si evince la difformità, la contraddizione fra i due termini del confronto. La persona dei coniugi non è trattata come deve, se la loro capacità procreativa si rapporta al processo procreativo solo in quanto donazione di gameti ad un terzo, che, manipolandoli secondo un protocollo collaudato, pone le condizioni del concepimento. La persona del concepito non è trattata come deve, se entra nell’essere mediante un’attività che, per la sua intima struttura tecnologica, istituisce un rapporto di produttore a prodotto. La persona del tecnico non è trattata come deve, poiché accettando di porre in essere un rapporto simile coi coniugi e col concepito, rinuncia alla sua dignità di persona.
Come si vede, richiamarsi — per contestare la verità di questa posizione — alle intenzioni dei coniugi, al loro progetto di vita e cose del genere, è semplicemente passare accanto al problema o porre un principio che, coerentemente sviluppato in tutte le sue implicazioni (è dovere il farlo), porta alla distruzione pura e semplice dell’etica, come sopra ho cercato di mostrare.
3. La domanda politica: quale società è degna dell’uomo?
La riflessione sulle procedure artificiali della procreazione, con tutte le possibilità aperte, hanno sempre più apertamente dimostrato che non è solo in questione il destino della singola persona, ma anche della società come tale.
Limitandomi alla casistica presa in esame dalla DV, in che senso può essere messa in questione la società umana come tale?
La società umana, in ciò che la caratterizza nei confronti di qualsiasi altro aggregato e la distingue, si costituisce sulla base di alcuni fondamentali presupposti. Essa presuppone in primo luogo il riconoscimento della identica dignità in ogni e singola persona umana, per il solo e semplice fatto che è persona umana: senza bisogno di ulteriori aggiunte. La conseguenza immediata di tutto ciò è che ogni persona possiede gli stessi diritti fondamentali. Per diritti fondamentali si intendono quelle capacità di esigere eticamente da ogni altro ciò che è immediatamente dovuto al puro e semplice fatto di essere persona umana.
Alla luce di questo semplice e primo presupposto si comincia già ad intravedere l’intima natura o verità del rapporto sociale umano. Esso è costituito dal reciproco riconoscimento, dall’affermazione di questa dignità della persona. Non è primariamente costituito dal principio dell’utile: mi associo perché mi è utile. È costituito dal principio della persona: mi associo perché è bene in sé e per sé. L’utilitarismo non crea un sociale umano; crea una convergenza, più o meno provvisoria, di interessi opposti. Il personalismo crea il vero sociale umano, poiché crea una comunione fondata sulla verità.
La considerazione degli embrioni umani come materiale di esperimento, resa possibile in larga parte dalla procreazione artificiale, è una delle più chiare espressioni del principio utilitaristico, elevato a norma fondamentale del sociale umano.
Ma c’è anche un’altra implicazione nella possibilità di procreare artificialmente. Nella procreazione artificiale è per sé irrilevante il matrimonio: si possono porre le condizioni del concepimento umano, prendendo i gameti da qualsiasi uomo e donna, sessualmente maturi. È irrilevante, dunque, come terminus a quo. Lo è ugualmente come terminus ad quem: può diventare padre-madre legalmente chi non lo è biologicamente. Per evitare equivoci, si faccia attenzione che la irrilevanza ad quem di cui stiamo parlando è di natura totalmente diversa dall’istituto giuridico dell’adozione. Questo, infatti, è lo strumento di cui ogni civiltà giuridica si è dotata, per dare una famiglia al bambino che si è trovato ad averne bisogno, per eventi umanamente non prevedibili.
La radicale e voluta separazione fra procreazione e matrimonio, fra paternità-maternità biologica e paternità-maternità legale distrugge uno dei fondamenti della socialità umana. Infatti, quella separazione attribuisce il potere di generare non a una reciprocità coniugale, fondata dall’amore, ma, alla fine, al potere politico. Inoltre, e di conseguenza, l’istituzione familiare è privata di ogni sua naturale consistenza, dal momento che la categoria che la definisce — la paternità/filiazione — non si fonda più su un dato obiettivo (la discendenza biologica) ma viene definita dalla legge civile. Infine, viene distrutto quel pluralismo delle società, poiché viene ad esistere solo la società politicamente intesa, dipendendo la famiglia completamente (anche nella sua definizione stessa) dalla legge dello Stato.
Conclusione
La DV — come è facile concludere da ciò che ho detto — costringe ad una riflessione seria, libera veramente dagli “idola fori”, oggi così potenti.
Costringe lo scienziato ad interrogarsi sul valore del suo modo specifico di conoscere la realtà: il valore noetico e le implicazioni etiche.
Costringe lo studioso dell’etica a ripensare i fondamenti stessi della sua riflessione: a lui è affidato, infatti, in primo luogo, la difesa della singolare preziosità di ogni persona umana.
Costringe il politico, cui è affidata l’elaborazione di un progetto di società umana, a chiedersi quale sia il criterio ultimo della sua progettazione.
In fondo, è compito essenziale della Chiesa porre la domanda non sui beni penultimi, parziali dell’uomo, ma sul Bene ultimo e intero dell’uomo: su ciò per cui deve avere un interesse illimitato.
|