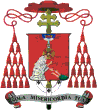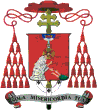LETTERATURA E FEDE
Biblioteca Ariostea: 13 aprile 2000
La formulazione del tema della mia riflessione è talmente generica da esigere subito di essere rigorosamente individuata nei suoi confini precisi. Non intendo parlare della presenza dei temi propri della fede nella letteratura moderna e contemporanea: non ho la competenza per farlo ed esistono già ricerche dedicate a quella presenza. La mia tematica è puramente formale. Vorrei rispondere alla seguente domanda: che rapporto esiste tra il discorso su Dio e sull’uomo in ordine a Dio e il discorso in genere artistico e in specie poetico?
Per afferrare meglio il senso della domanda, faccio due precisazioni attinenti ai due termini del binomio in questione. Il termine "fede" va qui inteso nel senso del discorso umano sul Dio che si è rivelato in Gesù Cristo. Questo discorso si articola in tre modi fondamentali. E’ discorso kerigmatico-catechetico: l’avvenimento della salvezza viene annunciato a chi non crede e spiegato nei suoi contenuti fondamentali a chi è "iniziato" al mistero cristiano. E’ discorso teologico-mistico: l’avvenimento della salvezza è offerto alla intelligenza del credente come "oggetto intelligibile-sperimentabile" perché ne abbia una "degna intelligenza" [S. Gregorio Magno]. E’ discorso apologetico: la rivelazione cristiana viene mostrata nella sua ragionevolezza a chi non crede o a chi ne contesta la ragionevolezza stessa. Come potete vedere, il discorso su Dio e sull’uomo in ordine a Dio denota un universo di significanti e di significati molto ricco e complesso. Quest’universo è da me questa sera connotato quando uso la parola "fede".
Il termine "letteratura" va qui inteso nel senso molto generico di espressione artistica, soprattutto espressione scritta e letteraria in senso stretto.
Ritornando allora alla domanda, l’ipotesi che vorrei verificare è la seguente: esiste un rapporto bi-direzionale, nel senso che la fede ha bisogno della letteratura e la letteratura ha bisogno della fede. Se si afferma un rapporto di reciproca necessità, con ciò stesso si afferma che fra fede e letteratura esiste un "aliquid" comune: che fra fede e letteratura non esiste (non può esistere) una distinzione adeguata.
Ora posso finalmente dire come si articolerà la mia riflessione: in tre punti. Nel primo cercherò di individuare il "luogo" dove fede e letteratura si incrociano: ciò che hanno in comune. Nel secondo cercherò di mostrare perché e in che senso la fede ha bisogno della letteratura. Nel terzo, di mostrare perché e in che senso la letteratura ha bisogno della fede.
1. LA STRUTTURA "SACRAMENTALE" DEL CONOSCERE
Così enunciato, questo momento della mia riflessione ha sicuramente richiamato al credente i sacramenti cristiani, cioè quelle azioni sacre attraverso le quali si compie l’opera della nostra salvezza.
Il richiamo non è fuorviante. Al contrario, esso ci aiuta più di ogni altro a capire di che cosa sto parlando: l’intelligibile nel sensibile ed il sensibile parte integrante-integrata nell’intelligibile. Questa connessione, questa "oppositività polare" [R. Guardini] costituisce l’oggetto adeguato del conoscere umano, come S. Tommaso non si stanca di ripetere [cfr. per es. 1,q.88,a.3], a causa del fatto che il nostro spirito [=ciò che fa sì che io sia spirituale e non solo un composto ordinato di molecole] "ex natura suae essentiae habet quod sit corpori unibilis" (1,q.75,a.7, ad 3um).
E’ questa costituzione della persona umana a far sì che "la sensibilità a tutti i livelli e l’intellitività in ogni suo aspetto sono destinate a lavorare cognitivamente-espressivamente l’una nell’altra, l’una con l’altra oscillando, mischiandosi e alternandosi. Sine sensu homo non intelligit, nec sine intellectu homo non sentit" [G. Sommavilla, Il bello e il vero. Scandagli tra poesia, filosofia e teologia, Jaca Book ed., Milano 1996, pag. 102].
Chiamo questa struttura del conoscere umano, struttura sacramentale. Penso che una delle analisi più fini di questa "sacramentalità" sia quella di C.S. Lewis in Le Lettere di Belicche e il brindisi di Berlicche [Jaca Book ed., Milano 1999, pag. 155-212]. Egli la chiama "trasposizione". Essa consiste nel trasferimento di una realtà superiore nella realtà inferiore, nella quale noi siamo in grado di percepire e capire la prima. "Potete dire che per mezzo della Trasposizione la nostra umanità, con i sensi e tutto, può divenire un veicolo di beatitudine. Oppure potete dire che i beni celesti, tramite la Trasposizione, sono già incarnati in questa vita, nella nostra esperienza temporale" (pag. 209). Agostino aveva stupendamente espresso questa legge quando scriveva, parlando dell’Incarnazione del Verbo, che "le cose che possono essere vedute solo dal cuore, venissero vedute anche dagli occhi" [Commento alla prima lettera a Giovanni, Discorso I, 1; cfr. infra].
Vorrei farvi due esempi di questa "struttura sacramentale" del conoscere umano, desunti da due esperienze umane fondamentali. La prima è costituita dalla scoperta del "tu materno" da parte del bambino ed il suo costituirsi in relazione dialogica con sua madre. "Quando la mamma per giorni e settimane intere ha sorriso al suo bambino, giunge il giorno in cui il bambino le risponde con un sorriso. Essa ha destato l’amore nel cuore del bambino e il bambino svegliandosi all’amore, si sveglia alla conoscenza: le vacue impressioni sensibili si raggruppano in logica disposizione attorno al nucleo del tu" [H.U. von Balthasar, Solo l’amore è credibile, ed. Borla, Torino 1965, pag. 78]. Nelle più umili esperienze sensibili, dentro alle sensazioni ha scoperto un "tu" unico, quello materno, ed attraverso esso ha fatto la scoperta di se stesso come un "io" amato e voluto: "incipe, parve puer, risu conoscere matrem" [Virgilio, Egloga IV].
La seconda esperienza è costituita dall’amore coniugale. Esso è la donazione di sé all’altro: atto eminentemente spirituale. E’ infatti percezione intelligente dell’unicità irripetibile della persona dell’altro/a: è un atto di visione intellettiva. Ed è quindi un atto di libertà, che consiste nel donarsi all’altro. Ma quest’evento eminentemente spirituale accade attraverso e nel corpo: è il corpo il linguaggio del dono. Ed il corpo è interiormente configurato per essere "sacramento" del dono: esso possiede un intrinseco significato sponsale, come è mostrato dalla correlazione mascolinità-femminilità. La scelta propria dell’amore coniugale, "la cui sorgente è la volontà di amare la persona dell’altro per se stessa, porta "l’io sono" ad una attuazione del proprio essere personale, che esige di compiersi in un superamento di se stesso effettivo….. Allora l’unità sostanziale della carne e dello spirito si realizza nel matrimonio del corpo e dello spirito" [P. Haegel, Le Corps, quel défi pour la persone, ed. Fayard, Paris 1999, pag. 273].
Citando un testo di S. Tommaso accennavo sopra che il conoscere umano è strutturalmente "sacramentale" a causa della costituzione metafisica della persona umana: unità sostanziale di corpo e spirito. E’ quindi accaduto che ogni negazione di questa unità ha comportato la negazione che la conoscenza umana fosse strutturalmente "sacramentale". Anche se già da tempo preparata, sappiamo che questa negazione viene introdotta [e non l’ha più lasciata!] nella nostra cultura da Cartesio. E da allora, la nostra visione dell’uomo ha sempre oscillato fra un dualismo che opta a favore dello spirito contro il corpo ed un monismo riduttivo o dello spirito quando si afferma esistenza solo della materia o del corpo quando si afferma l’esistenza solo dello spirito. Dissociazione che fu poi accentuata letterariamente da J. Milton. A quale situazione essa ci abbia condotto credo che sia stato espresso nel modo più alto da T.S. Eliot nel secondo dei Quattro Quartetti [East Coker III]: "E si vede che dietro ogni faccia si spalanca il vuoto mentale/E non resta che il crescente terrore di non aver nulla a cui pensare".
L’affermazione della struttura sacramentale della conoscenza umana costituisce il "quid commune" fra fede e letteratura; la sua negazione le dissocia, introducendo un dissesto grave nella costituzione di entrambe.
2. LA FEDE HA BISOGNO DELLA LETTERATURA
"Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita … noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi" (1Gv 1,1-3). E’ uno dei testi-chiave di tutta la Rivelazione cristiana.
Esso in primo luogo descrive ciò che semplicemente è il cristianesimo: la Vita si è fatta visibile! E pertanto Dio stesso poté essere udito, veduto, toccato. Agostino, commentando quel testo, scrive: "Ma come questa vita si è resa visibile? Essa era, infatti, fin da principio; ma non era resa visibile agli uomini; si era resa visibile, invece, agli angeli, che la contemplavano e se ne nutrivano come di loro pane. Ma che cosa dice la Scrittura? dice: "l’uomo mangiò il pane degli angeli". Dunque la vita stessa si è resa visibile alla carne: e si è posta nella condizione di essere veduta affinché quelle cose che possono essere vedute solamente dal cuore venissero vedute anche dagli occhi per poter guarire i cuori. Infatti il Verbo si vede solamente col cuore; invece la carne si vede anche con gli occhi del corpo. Pertanto ci era possibile vedere la carne, ma non ci era possibile vedere il Verbo; per questo "il Verbo si è fatto carne"" [Commento alla prima lettera di Giovanni, discorso I, 1; Rusconi Libri ed., Milano 1994, pag. 80-81].
L’incontro con Dio non avviene attraverso una rinuncia alla propria sensibilità, se non nella misura in cui questa si è disintegrata dallo spirito. L’incontro con Dio avviene attraverso la nostra corporeità: "ciò che noi abbiamo udito…". E’ questa l’assoluta originalità del cristianesimo: Verbum-caro.
Quanto Giovanni ha descritto come esperienza vissuta da lui e dagli apostoli in parte appartiene a loro esclusivamente [contemplare – toccare colle mani: all’aoristo, azione puntuale accaduta nel passato], ma nella sua sostanza si continua anche oggi come possibilità offerta a tutti [vedere – udire; al perfetto]. E si continua sempre colla stessa modalità, mirabilmente espressa da un Prefazio del Natale: "conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all’amore delle realtà invisibili". Questa modalità nel suo intero è la Chiesa: essa costituisce la via visibile mediante la quale siamo introdotti nel mondo invisibile.
Questo modo di "vedere" la Chiesa implica però la messa in atto di tutto l’essere umano-cristiano della persona: la sua sensibilità, la sua ragionevolezza, la sua fede. Non staccate o disintegrate l’una dall’altra, ma unificate in un "integrum" all’interno del quale ciascuna dimensione umana si realizza in pienezza perché in sub-ordine alla dimensione superiore: la sensibilità alla ragionevolezza, la ragionevolezza alla fede.
Questo modo di "vedere la Chiesa" oggi è spesso assente nei cristiani stessi, sbilanciati o verso il basso o verso l’alto. Verso il basso: parlare, vedere e capire la Chiesa "come se" essa esistesse e potesse esistere senza Gesù Cristo. Verso l’alto: parlare e capire la Chiesa come fosse una "idea" cui non corrisponde mai nulla nella realtà, se non una vaga tensione verso un orizzonte mai storicamente raggiungibile. Ritornerò fra poco su questa visione strabica della Chiesa.
Per mostrarvi la modalità "sacramentale" del nostro incontro col Mistero nella Chiesa, attiro la vostra attenzione sulla manifestazione più alta della Chiesa stessa, la liturgia. Essa è l’unità tra "materiale-immateriale", "visibile-invisibile": è la sintesi della visione cristiana della realtà. Come è stato scritto giustamente: "gli edifici decorati secondo principi ben stabiliti diventano immagine simbolica del cosmo, mentre il dramma liturgico che si svolte attualizza tutta l’azione salvifica di Dio, e anticipa la glorificazione escatologica della creazione e della storia" [F. Bouwen, Histoire spirituelle de l’Orient chrétien des grandes Conciles à nos jours, in Christus 155 (1992), pag. 266]. Chi vive profondamente una celebrazione liturgica ne esce trasfigurato. E la vera incultura non è precisamente non saper leggere né scrivere: è l’incapacità di vivere questa esperienza del sensibile come presenza del Mistero.
Ma quando la Liturgia è vista nel modo sbagliato? Quando (verso il basso) è vista e celebrata come semplice incontro umano dentro cui non dimora il Mistero; oppure quando (verso l’alto) è vista e celebrata come necessaria evasione dalle brutte faccende feriali.
Ora siamo finalmente in grado di capire perché la fede ha bisogno della letteratura intesa come "linguaggio ed opera artistica". Devo però preliminarmente dire finalmente con più precisione a che cosa penso quando parlo di letteratura, "linguaggio ed opera artistica".
E’ un’esperienza, credo, che tutti abbiamo fatto. Quando abbiamo letto con la necessaria attenzione interiore qualche grande poesia, questa ci ha fatto ri-accorgere di realtà colle quali eravamo da sempre in contatto [la luna, l’acqua, il tramonto, la notte …] o ri-appropriare quelle esperienze di cui è impastata la nostra giornata [l’amore, il dolore, la morte, l’amicizia…]. In fondo la poesia ci libera dalla più grave malattia dello spirito: l’evasione dalla realtà, l’evasione dal "normale". E lo fa perché ci introduce dentro al Mistero di cui la realtà è segno e presenza. Il vero poetare quindi è un atto eminentemente sintetico perché esso è frutto di sensibilità ed intelletto che legge ciò che i sensi confusamente percepiscono, e ne cerca il significato. T.S. Eliot ha scritto giustamente che la poesia ha come scopo di renderci: "un po’ più consci delle profonde sensazioni senza nome che formano il substrato del nostro essere, nel quale raramente penetriamo; perché la nostra vita è soprattutto una costante evasione da noi stessi, e un’evasione dal mondo visibile e sensibile" [cit. da T.S. Eliot, La sorella velata. Poesie scelte, BUR, Milano 2000, pag. 281].
Esiste allora una profonda "armonia prestabilita" fra Avvenimento cristiano proclamato, capito-espresso, difeso e celebrato da una parte, e linguaggio ed opera artistica dall’altra. Sia l’uno che l’altra hanno una struttura sacramentale. E la storia, non per caso quindi, dimostra questa profonda vicinanza.
L’avvenimento cristiano pertanto o si dice artisticamente, letterariamente o si dice male. "Male" significa che non si dice nel modo corrispondente al suo contenuto essenziale: Verbum-caro. Certamente, e non dobbiamo mai dimenticarlo neppure un istante, la religione cristiana si è sempre presentata come la religione vera. Essa cioè non ha mai presentato se stessa come una semplice variante culturale dell’esperienza religiosa dell’uomo chiusa in chiave simbolica: essa ha detto di sé di essere l’unica religione vera. Pertanto cadremmo in un grave equivoco se intendessimo il discorso precedente nel senso di un cristianesimo dal quale la dimensione veritativa fosse assente o non fosse la dimensione costitutiva. Ma questo non significa che sia falso quanto detto sopra, ma che è necessario il recupero della più profonda definizione di bellezza: "splendor veri – splendore della verità" [cfr. S. Tommaso d’A., 1,5,4, ad1um] che genera attrazione in chi lo vede-capisce, poiché – come scrive S. Tommaso - "La contemplazione spirituale della bellezza genera l’amore" (1,2,27,1 ad 3um). Ma siamo già nel terzo ed ultimo punto della nostra riflessione.
3. LA LETTERATURA HA BISOGNO DELLA FEDE
Consentitemi di iniziare questo ultimo punto della mia riflessione citando un brano di una poesia di Leopardi, Aspasia:
Raggio divino al mio pensiero apparve,
Donna, la tua beltà. Simile effetto
Fan la bellezza e i musicali accordi,
Ch’alto mistero d’ignorati Elisi
Paion sovente rivelar. Vagheggia
Il piagato mortal quindi la figlia
Della sua mente, l’amorosa idea,
Che gran parte d’Olimpo in sé racchiude,
Tutta al volto ai costumi alla favella
Pari alla donna che il rapito amante
Vagheggiare ed amar confuso estima.
Or questa egli non già, ma quella, ancora
Nei corporali amplessi, inchina ed ama.
Alfin l’errore e gli scambiati oggetti
Conoscendo, s’adira; e spesso incolpa
La donna a torto …
[vv. 33-48]
Penso che questa pagina leopardiana sia una delle più alte espressioni della condizione umana, della condizione in cui la modernità ha imprigionato l’uomo, e della verità della poesia [come di ogni arte].
Esprime la condizione umana come condizione definita dalla sproporzione fra il desiderio dell’uomo e la realtà colla quale l’uomo ha a che fare: la realtà, per esempio, dell’amore con cui un uomo ama una donna. "Ciò che" desidero è più che di "ciò che esperimento". Questa definizione di uomo non è il risultato in primo luogo di una ricerca intellettuale, ma totalmente un avvenimento esistenziale. Ed è per questo che la consapevolezza di questa condizione contraddittoria è presente in tutti i grandi poeti da Sofocle a Leopardi, da Virgilio a Baudelaire, da Dante a Hölderlin, ed in tutti i grandi filosofi e teologi da Platone a Tommaso, da Agostino a Kant.
Ma nella consapevolezza di questa contraddizione, l’uomo moderno è stato condotto da falsi maestri dentro ad una prigione [immagine kafkiana] dalla quale pare che non riesca più ad evadere. "Vagheggia/ Il piagato mortal quindi la figlia/ Della sua mente, l’amorosa idea/ Che gran parte d’Olimpo in sé racchiude", dice il poeta. Il "di più" che l’uomo avverte quando vive [quando ama e quando lavora, quando soffre e quando muore, quando subisce ingiustizia e quando è tradito] non è una Presenza, ma un "idea" prodotta dalla mente umana alla quale non corrisponde nulla. Questa è la definizione della condizione in cui versa l’uomo di oggi: vivere negando che esista la verità, una corrispondenza cioè fra il suo spirito e la realtà [adaeguatio rei et intellectus]. Anzi vivere come se lo stesso problema della verità non fosse di primaria importanza. Come scrive U. Eco nel suo più famoso romanzo Il nome della rosa: " …L’unica verità si chiama: studiare, per liberarsi dalla passione morbosa per la verità". E se Leopardi, come tutti i grandi della modernità, "Alfin l’errore e gli scambiati oggetti/ Conoscendo, s’adira; e spesso incolpa/ La donna a torto…", oggi né ci si adira né si incolpa la realtà di non essere a misura del desiderio. Oggi ci si diverte semplicemente, in senso pascaliano.
Ed è in questo contesto che si pone la verità della poesia e dell’arte. Essa deve richiamare al realismo della condizione umana: la vera arte non bara col vivere umano. Richiamare l’uomo, che oggi non sopporta più troppa realtà, fuori da "quel dualismo che da Cartesio all’idealismo, dallo spiritualismo allo scientismo di varia coloritura, separa l’uomo dal reale, l’io dal mondo, in definitiva, il destino dall’istante"; mostrare all’uomo la via per riscoprire la possibilità della incarnazione dell’Ideale nel normale [cfr. D. Rondoni, in T.S. Eliot, La sorella velata, cit. pag. 6.7].
In una parola, la poesia, ogni arte, guida l’uomo a leggere la realtà come "segno". "Che cos’è un segno? Un segno è una realtà sperimentabile il cui senso è un Altro. Se uno guarda quell’oggetto con occhio umano – e perciò con la ragione – si sente rimandato ad Altro" [L. Giussani, in G. Leopardi, Cara beltà, BUR ed., Milano 1996, pag. 19].
Questo modo di vivere è talmente inevitabile per chi non si accontenta di "lasciarsi vivere", per chi è vero e grande poeta, che una delle testimonianze più alte ci è data proprio da un ateo convinto e radicale come L. Pirandello. Penso alla novella Il treno ha fischiato. E’ ben noto il contenuto. Un uomo costretto solamente a lavorare giorno e notte: "vecchio somaro, che tirava zitto zitto, sempre d’un passo, sempre per la stessa strada la carretta, con tanto di paraocchi". Ma una notte non riesce a dormire, e sente il fischio di un treno: in quel fischio che gli faceva immaginare un viaggio senza fine, quell’uomo si accorge della realtà. "Tutto il mondo, dentro d’un tratto: un cataclisma". E venne portato in manicomio [L. Pirandello, Novelle per un anno, vol. 1-tomo 1, ed. Mondatori, Milano 1985, pag. 662-670]. Ma chi è pazzo, cioè fuori dalla realtà, Don Chisciotte o Sancho?
E’ a questo livello, cioè al centro dell’esperienza che la definisce, che la poesia e l’arte incontrano la fede: più precisamente l’esperienza della fede cristiana. Essa è il compimento del cammino poetico poiché afferma, celebra e vive la realtà del Mistero dentro a questo mondo: "il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi". Ed è compimento che trasfigura tutto il cammino umano: Dante ed Eliot ne sono i due testimoni più grandi, a mio giudizio.
Conclusione
Mentre scrivevo queste confuse riflessioni, non cessava di ritornarmi alla mente una famosa pagina del Fedro, dove si narra l’incontro del dio Theuth con il re Thamus, al quale il dio aveva portato l’invenzione della scrittura, "farmaco della memoria e della sapienza".
"E il re rispose: "….La scoperta della scrittura … avrà per effetto di produrre la dimenticanza nelle anime di coloro che la impareranno, perché, fidandosi della scrittura, si abitueranno a ricordare dal di fuori mediante segni estranei, e non dal di dentro e da sé medesimi: dunque, tu hai trovato non il farmaco della memoria, ma del richiamare alla memoria. Della sapienza, poi, tu procuri ai tuoi discepoli l’apparenza, non la verità … e sarà ben difficile discorrere con loro, perché sono diventati conoscitori di opinioni invece che sapienti"" [274e-275b; trad. di G. Reale: Fondazione L. Valla/Mondandori, Milano 1998, pag. 157].
La poesia, l’arte tradiscono se stesse quando riducono il parlare, l’esprimere fine a se stesso, introducendo l’uomo nella prigione dell’evasione nichilista. Eludendo la realtà, sorreggendosi come in un sorta di tensione narcisistica, negandosi ad ogni referente che non sia il puro discorrere, se – come scrisse P. Bigongiari – "La realtà, per essere tale, non può che essere inventata: il che vuol dire: venire dopo la nera realtà pratica" [cit. da G. Quiriconi, I miraggi, Le tracce, Jaca Book ed., Milano 1989, pag. 225], allora davvero "sarà ben difficile discorrere con loro", poiché ti daranno certo qualche nuova opinione, non ti renderanno sapienti. Non ti daranno il gusto di vivere. Ed è ciò che oggi spesso accade. Ma, come disse M. Luzi: "il tempo irritato o sconvolto, questo tempo tragico consente e forse tragicamente propizia la poesia" [Cit. da G. Quiriconi, op. cit., XIII] e la fede.
|