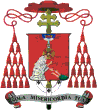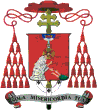Intervento alla presentazione del libro di Marcello Pera
"Perché dobbiamo dirci cristiani. Il liberalismo, l’Europa, l’etica"
Istituto Veritatis Splendor, 5 maggio 2009
La mia riflessione si articolerà in una premessa, due punti centrali, ed alcune osservazioni conclusive.
La premessa. Ogni volta che leggo un libro, e questo appartiene ai pochi che vale la pena leggere interamente, alla fine mi faccio sempre una domanda: a quale interrogativo fondamentale esso intende rispondere? Quale problema risolvere?
Se non vado errato, la domanda fondamentale del libro è la seguente: come impedire che crolli la "casa" – l’ethos direbbero i greci – che l’Occidente ha costruito come dimora degna dell’uomo? Il problema cioè che il libro intende risolvere è di ridare stabilità ad un edificio che sta mostrando crepe talmente pericolose da preludere al crollo.
Mi fermo un momento per chiarire che cosa denota questa metafora della casa/edificio. A diversità degli altri animali, l’uomo si colloca nella realtà, dentro al mondo in cui vive, non solo in modo da assicurarsi la sopravvivenza individuale e specifica. Egli desidera naturalmente una collocazione buona e vera, non solo utile e piacevole: desidera un modo di essere e un modo di stare nella realtà che sia proporzionato, adeguato alla sua natura di persona. Per esemplificare: non un qualsiasi modo di vivere in società, ma il modo giusto.
Tutto questo io intendo quando parlo di "casa" di "dimora", di "edificio" degno dell’uomo.
Ovviamente la domanda di fondo genera logicamente due sottodomande: a/ di che dimora si sta parlando, quale è il suo nome? b/ perché si afferma che essa è a rischio di crollo?
Anticipando ora, per chiarezza, quanto spero di poter dire più diffusamente dopo, alla prima domanda l’autore risponde: la dimora di cui sto parlando è il liberalismo, inteso e come dottrina antropologica e come dottrina etica e come dottrina politica. La domanda di fondo quindi del libro si precisa nel modo seguente: come impedire che la configurazione, l’architettura liberale secondo cui l’uomo occidentale ha costruito la sua dimora sia demolita?
La risposta alla domanda b/ ci introduce già nello schema argomentativo di tutto il libro, articolato in tre capitoli. In ognuno di essi si parte dal condurre il visitatore dentro la casa per mostrargli le gravi crepe. Fuori metafora. Si dimostrano le aporie, le difficoltà teoretiche e pratiche del liberalismo sia in generale [primo capitolo] sia alla prova di due fatti [corrispondenti rispettivamente al secondo e terzo capitolo]: l’unificazione europea; l’elaborazione di un’etica pubblica che sia capace di far convivere non da stranieri morali ma da veri con-cives persone di culture diverse.
La diagnosi nei tre casi è identica: le ragioni delle gravi difficoltà sia inerenti alla teoria generale del liberalismo sia inerenti ai due casi su indicati sono tutte riconducibili ad una sola, il divorzio dal cristianesimo. La vera causa per cui la dimora che l’uomo europeo ha costruito per vivere una buona vita sta crollando, è che da essa è stato espulso il cristianesimo.
È stato espulso perché estraneo e perfino pericoloso per la stabilità della casa? Così si è pensato, e si pensa da parte di molti. In realtà, l’autore nel terzo momento argomentativo di ogni capitolo dimostra che l’errore è stato precisamente di pensare questo. Al contrario l’espulsione del cristianesimo non è nella logica interna del liberalismo, ma una sua deviazione. Deviazione che precisamente ha portato alle difficoltà ed aporie attuali.
La conclusione è allora logica: per uscire da questa condizione è necessario, "dobbiamo dirci cristiani".
Per chiarezza – e termino la lunga premessa – richiamo i quattro momenti che costituiscono lo schema argomentativo di ogni capitolo: (a) difficoltà ed aporie della situazione attuale; (b) causa delle difficoltà ed aporie è stato il divorzio dal cristianesimo; (c) il divorzio non è dovuto ad incompatibilità intrinseche, ma piuttosto a ragioni esterne; (d) ragioni per cui "dobbiamo dirci cristiani".
Vorrei ora non fare il riassunto del libro, di cui raccomando vivamente la lettura, ma limitarmi a due ordini di riflessioni.
1. Non si capisce né la tesi dell’autore né l’argomentazione che la sostiene se non si ha chiaro il contenuto dei termini – chiave di tutto il libro: cristianesimo e liberalismo.
Per capire il significato del primo termine è fondamentale la distinzione fatta dall’autore fra cristiani per fede e cristiani per cultura. Il titolo del libro nella proposta dell’autore è "perché dobbiamo dirci cristiani per cultura" e non "… per fede". La cosa va attentamente spiegata.
La vera identità di Gesù di Nazareth può essere riconosciuta solo mediante la fede, e la sua presenza nella storia avviene mediante la fede dei suoi discepoli.
Ma è ugualmente vero che la fede in Gesù genera uno stile ed una forma stabile di vita, un modo proprio di vivere l’esperienza umana nelle sue fondamentali dimensioni, un modo proprio di collocarsi nella realtà. In una parola: la fede nel rigoroso significato teologico genera una cultura.
Orbene nei confronti di una cultura generata dalla fede possiamo dire che la sua rilevazione ed il suo riconoscimento, la rivelazione del suo dato obiettivo, non esige la fede in Cristo. Non solo, ma più profondamente: nella cultura generata dalla fede può ritrovarsi anche il non-credente, in quanto essa corrisponde alle esigenze della ragione: Tommaso direbbe che ci troviamo sub metis philosophiae [cfr. Super Boetium de Trinitate 2,3,3m]. Certamente – e l’autore lo sottolinea con grande forza – è necessario non rifiutarsi, per questo, ad un uso completo della ragione; non censurare la sua esigenza e la sua domanda di una risposta esplicativa dell’intero dell’essere.
Quando dunque l’autore parla di "cristianesimo-cristiani per cultura" intende la capacità della persona di rilevare un universo di significato nel suo legame genetico dalla fede cristiana, e di riconoscere in questo universo una risposta adeguata e vera alle esigenze della sua umanità. Coloro dunque che vivono in questa attitudine sono cristiani, ma di cultura non di fede. L’autore afferma che di questo cristianesimo ha bisogno il liberalismo; ha bisogno l’Europa; ha bisogno l’etica pubblica della società occidentale, se non vogliono perire.
Ho chiarito il primo termine. Aggiungo una riflessione a questa chiarificazione. L’autore mi è sembrato teoreticamente assai corretto nell’affrontare un tema – il rapporto fede/ cultura – molto dibattuto nella teologia cristiana. La sua posizione in sostanza evita sia la posizione di chi afferma che parlare di cultura cristiana, è dire una contradictio in adjecto sia la posizione di chi finisce col pensare alla possibilità di identificare fede e cultura, individuando una cultura precisa [solitamente quella occidentale] come la cultura cristiana. Ma riprenderò in una delle osservazioni finali questo tema centrale.
Il secondo termine liberalismo, come riconosce l’autore stesso, non è oggi di facile definizione. Mi limito a dire ciò che io ho capito essere secondo l’autore il significato del termine. Riconosco che schematizzo notevolmente.
Liberalismo denota una visione dell’uomo che ruota attorno ad un nucleo. "Si tratta dell’idea dei diritti naturali (o altrimenti chiamati "umani", "fondamentali", "essenziali", "di base", eccetera): tutti gli uomini sono liberi e uguali per natura e le loro libertà fondamentali sono antecedenti allo Stato e non coercibili dallo Stato" [pag. 15]. Dunque, la caratteristica definitoria dell’antropologia liberale è l’affermazione del primato ontologico ed assiologico della singola persona umana, primato che prende corpo nell’ascrizione ad ogni uomo come tale di certe libertà-diritti fondamentali.
Non è ora il caso di esplicitare tutte le implicazioni intrinseche ad una tale ascrizione. L’autore lo fa soprattutto nel primo capitolo. Mi limito ad una che, come si vedrà in seguito, è di importanza fondamentale. Humanitas nel vocabolario liberale non è un mero flatus vocis: è un universale in re. Denota una reale partecipazione di ogni singola persona alla stessa natura umana: esiste quindi una natura della persona umana.
Chiariti i due termini del confronto, possiamo ora prendere coscienza più chiara della tesi centrale del libro: poiché esiste un legame storico e concettuale fra liberalismo e cristianesimo, avere reciso questo legame ha portato il liberalismo dentro una crisi senza uscite; ricostruire questo legame è ciò che oggi è richiesto se l’Europa non vuole dilapidare la sua identità propria. E sono così arrivato alla seconda riflessione.
2. In questo secondo punto della mia riflessione non intendo presentare l’argomentazione messa in atto dall’autore per dimostrare la sua tesi. Le mie intendono essere "reazione" alla tesi centrale e a tutto l’impianto argomentativo.
Parto dalla tesi centrale. Per mostrare il mio accordo con l’autore, mi servo della distinzione fra l’ordine della giustificazione [context of justification] e l’ordine della scoperta [context of discovery].
Penso che quanto all’ordine della scoperta sia difficile contestare la tesi dell’autore: è stata la Rivelazione cristiana a condurre l’uomo alla consapevolezza della sua dignità della persona. Dignità di persona che implica una presa di posizione quanto allo statuto ontologico della persona. Tommaso scrive "persona est id quod est perfectissimun in ratione entis". Dignità di persona che implica un giudizio di valore circa la persona stessa: non esiste realtà che valga più che una persona ["che importa all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde se stesso"]. Coglie il vero Kierkegaard quando dice che la categoria del singolo è centrale nel cristianesimo, e che persa questa il cristianesimo è finito.
Quanto all’ordine della giustificazione, non c’è dubbio – e l’autore lo nota accuratamente – che è possibile teoreticamente un’argomentazione puramente razionale per fondare quella verità circa l’uomo storicamente fatta conoscere all’uomo dalla rivelazione cristiana.
Se non vado errato, l’autore pensa che questa operazione teoretica e pratica, debba essere compiuta con grande vigilanza pratica e teorica. La mancanza di una tale vigilanza ci ha condotti all’attuale situazione. La tesi dell’autore è che quando i Padri del liberalismo classico costruivano il nucleo della dottrina come operazione ragionevole semplicemente, essi lavoravano in un contesto cristiano, ed in fondo traducevano nel linguaggio della ragione quanto la fede cristiana aveva insegnato all’Europa.
Il passaggio in aliud genus è stato quando la costruzione razionale non è più stata fatta "a prescindere dalla fede cristiana", ma "contro la fede cristiana". L’espressione più inequivocabile di questa ambiguità è il pensiero di Croce, pensa l’autore: il passaggio in aliud genus è il necessario sviluppo dello Spirito dentro al Storia oppure è un tagliare le radici alla pianta? L’autore pensa che l’avere intenzionalmente de-contestualizzato il liberalismo dal contesto della sua scoperta, è stata la sua condanna a morte.
Ma ciò che nel libro mi ha colpito maggiormente è stata la dimostrazione della tesi centrale operata attraverso la sua verifica in tre ambiti oggi di urgente attualità: il rapporto relativismo-democrazia liberale; la categoria del "patriottismo costituzionale" o dell’autosufficienza del liberalismo politico; la costituzione di un’etica pubblica.
Anche per ragioni di brevità, vorrei tentare di trattare sinteticamente le tre verifiche, tenendo conto di ciò che li accomuna. Come spero risulti dal seguito del discorso.
Partiamo dalla c.d. autosufficienza del liberalismo politico, così come viene pensata soprattutto da J. Habermas. Autosufficienza significa che lo Stato, o altri organismi politici sovra-statali [il libro parla dell’unificazione europea], dopo la completa positivizzazione del diritto, si giustifica non in forza di presupposti metafisici o religiosi [come era il ricorso alle dottrine classiche del diritto naturale], ma solo in forza di un consenso di fondo dei cittadini, preferibilmente formalizzato [si veda a pag. 78]. In altre parole, come scrive J. Habermas [citato dall’autore a pag. 79]: "ciò che lega insieme una nazione di cittadini – a differenza di una nazione di connazionali in senso etnico – non è una qualche forma di sostrato primordiale, bensì il contesto intersoggettivamente condiviso di un’intesa possibile".
Due sono dunque i presupposti dell’auto-sufficienza. Primo: lo Stato secolarizzato e post-metafisico non ha bisogno di presupposti esterni per mantenersi, né ha bisogno di ricorrere a tradizioni diverse dalle proprie per assicurarsi la lealtà dei cittadini. Esso basta a se stesso. Secondo: il rapporto politico è esclusivamente un rapporto giuridico in una perfetta corrispondenza fra costituzione e leggi ordinarie. A questo punto si capisce molto bene che ispirati a questa teoria, i Padri attuali costituenti dell’Europa unita abbiamo rifiutato qualsiasi riferimento alle radici greche, latine, giudeo-cristiane. Inoltre si capisce bene come l’ingresso della Turchia nell’unione europea non costituisca nessun problema.
Come scrive l’autore qui si "promette di dare all’Europa l’identità e con essa la nazione che le manca per unificarsi, senza attingere a fonti diverse da quelle strettamente politiche". Come è noto, il progetto è fallito. Per quale ragione? L’autore parla giustamente di una grave "lacuna etica" in questa costruzione [cfr. pagg. 86-90]. Mi fermo un poco su questo punto nodale, e così concludo questo secondo punto.
Parto da un testo di Leopardi.
"Se l’idea del giusto e dell’ingiusto, del buono e del cattivo morale non esiste o non nasce per sé, nell’intelletto degli uomini, niuna legge di niun legislatore può far che un’azione o un’omissione sia giusta né ingiusta, buona né cattiva. Perocchè non vi può esser niuna ragione per la quale sia giusto né ingiusto, buono né cattivo, l’ubbedire a qualsivoglia legge, e niun principio vi può avere sul quale si fondi il diritto che alcuno abbia di comandare a chi che sia" [Zibaldone 3349-3350].
Il testo leopardiano pone la domanda di fondo: esiste qualcosa di ingiusto in sé e per sé e che non potrà mai essere giustificato da nessuna procedura legittima? In altre parole: esiste una verità circa il bene dell’uomo indipendentemente dai risultati dell’argomentazione, discussione e deliberazione pubblica? Esiste e non può che essere il riconoscimento di ciascuno da parte di ciascuno dell’uguale dignità di persona. Nel momento in cui affermo che non c’è bisogno di alcun diritto naturale oggettivo, ma che la procedura democratica è l’unica fons essendi della legittimità, delle due l’una. O penso questa procedura come scontro di interessi opposti la cui unica soluzione è l’imposizione del più forte o penso questa procedura come il modo degno dell’uomo per trovare quella soluzione in cui possa riconoscersi la ragionevolezza di ognuno. Nel primo caso esco per definizione dalla società liberale; nel secondo caso resto nella società liberale ma perché presuppongo e la uguale dignità di ogni persona e il possesso da parte di ciascuno della stessa ragionevolezza o natura ragionevole. Questa è l’idea tommasiana di legge e diritto naturale.
J. Habermas è stato costretto a giungere a queste condizioni, affermando che la legittimazione di una carta costituzionale da parte del popolo non può limitarsi al computo aritmetico di maggioranze-minoranze. Essa deve fondarsi su una argomentazione ragionevole "dotata di sensibilità alla verità". Non è difficile concludere allora che i partiti politici non possono assicurare la presenza di una tale sensibilità da se soli, essendo per loro stessa natura preoccupati prevalentemente di interessi di parte.
Sempre Habermas nella sua opera Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale [Einaudi (originale 2001), Torino 2002] esclude che questioni di genetica umana possono essere risolte con procedure democratiche.
La verifica di queste tesi generali possiamo averla secondo l’autore quando si affronta il tema di un’etica pubblica e tema collegato del relativismo, che genera il multiculturalismo.
Mi limito ad una sola riflessione. Negata che esista una verità circa il bene dell’uomo o – il che coincide – che esiste una natura umana ragionevole, i diritti fondamentali dell’uomo vengono pensati e praticati come ciò che il singolo individuo preferisce per sé, et de gustibus non est disputandum.
Ciò ha una conseguenza devastante sull’idea di legge civile e sul compito del legislatore. La nuova idea è che lo Stato e la legge non devono vietare ciò che l’individuo preferisce. E con ciò la coesione sociale è insidiata alla sua origine stessa. La soluzione del problema non è il ricorso al principio "se tu non vuoi, perché io non posso?", col varo cioè di leggi, né impositive né coercitive, ma permissive. Il non volere colmare la lacuna etica, e un’autosufficienza liberale non può farlo senza rinunciare al principio dell’autolegislazione civile, porta alla disgregazione delle nostre società occidentali. L’aver sostituito la ragione pratica colla ragione comunicativa ha cambiato sostanzialmente tutto il discorso etico pubblico.
L’autore sostiene la tesi che c’è una sola via di uscita da questa crisi: il ritorno al contesto di scoperta del liberalismo, alla sua radice, al cristianesimo. Sono s’accordo, pur tenendo conto di ciò che dirò fra poco nella prima osservazione finale. Quale è la ragione ultima dell’accordo? Lo dico schematicamente.
Esistono due sistemi di riferimento quando pensiamo e pratichiamo la nostra vita associata. Chiamo il primo, sistema di riferimento il prossimo; chiamo il secondo, sistema di riferimento membro della comunità. Il primo connota l’interrelazione tra tutti gli uomini sul principio di umanità; il secondo connota l’interrelazione fra alcuni uomini sul principio di una qualità inerente all’umanità.
Il primo trascende il secondo, ne è superiore, e rende ragione fino in fondo di ciò che è contenuto in qualsiasi sistema del tipo "membro della comunità".
È precisamente questo che Gesù ha insegnato nella parabola del samaritano ed il senso ultimo del comandamento dell’amore. Paolo ne ha fatto uno dei punti centrali: non è più necessario essere "membro di comunità" per essere redenti. In Cristo non esiste più né gentile né ebreo, né greco né barbaro, né schiavo né libero, né uomo né donna.
Il liberalismo ha elaborato una dottrina politica sulla base di questa verità cristiana, affinché nella convivenza e nella cooperazione umana a vari livelli e nei vari legami, il "sistema di riferimento il prossimo" fosse quello decisivo: ogni uomo in forza della sua stessa umanità ha dignità uguale ad ogni uomo.
Sono così giunto alle due osservazioni finali. La prima riprende la distinzione "cristiani per cultura"-"cristiani per fede"; la seconda riguarda la lettera di Benedetto XVI premessa al libro.
La prima osservazione è ciò che ho pensato a lettura terminata. Non la si rinviene nel libro. Correttamente l’autore non la introduce. La presenza di Cristo dentro ad una cultura è assicurata esclusivamente dalla fede dei suoi discepoli, la quale non è destinata a rimanere confinata nell’intimo della coscienza del singolo né a supposte comunità di discepoli separate dal mondo. Essa, la fede dei discepoli, deve imprimere nel mondo e nel vissuto umano la forma Christi, di cui solo la fede è trasmettitrice. La possibilità dell’esistenza di "cristiani per cultura" è assicurata esclusivamente dall’esistenza di "cristiani per fede".
Ne deriva che la "forma Christi" in una cultura declina, quando declina la fede dei discepoli del Signore, dalla quale quella "forma" è mediata.
Viene allora da chiedersi: il distacco dell’edificio culturale dal suo stile cristiano è dovuto anche [o soprattutto?] dal declino della fede nei cristiani europei? Dall’indebolirsi della confessione della fede nella Chiesa in Europa?
La seconda osservazione riguarda la lettera di Benedetto XVI all’autore e posta all’inizio del testo. È un fatto troppo nuovo per essere trascurato.
La lettera fa cinque affermazioni che è agevole individuare, e nelle quali secondo il Pontefice consiste la sostanza del libro. A me sembra che tutte e cinque si pongono senza difficoltà dentro al pensiero di J. Ratzinger e al Magistero di Benedetto XVI. Ma data la chiarezza icastica con cui sono espresse, la lettera è un notevole contributo per uscire dalla confusione in cui non raramente versa il dibattito in corso fra cristianesimo e mondo contemporaneo. Mi limito dunque a due osservazioni marginali.
Come Benedetto XVI ha richiamato varie volte, un dialogo interreligioso vero e proprio è possibile e doveroso solo fra cristiani ed ebrei. Difficile, certo, ma imprescindibile per chi voglia essere veramente discepolo del Signore.
Infine, è davvero necessario ed urgente uscire dalla crisi in cui versa oggi l’etica pubblica. Non si può continuare a vivere in questa situazione: si rischia troppo.La proposta teoretica dell’autore è un vero contributo al riguardo, colla sua affermazione "politicamente assai scorretta" che l’etica pubblica liberale esige una concezione sostanziale di vita buona, e che questa è congeniale a quella cristiana.
Alla fine, condivido pienamente il giudizio del S. Padre: "il presente libro è … di fondamentale importanza in quest’ora dell’Europa e del mondo". Ancora una volta ho costatato che soltanto mediante una rigorosa meditazione filosofica [e teologica] può emergere nella sua più limpida chiarezza il problema presente in un momento storico.
|